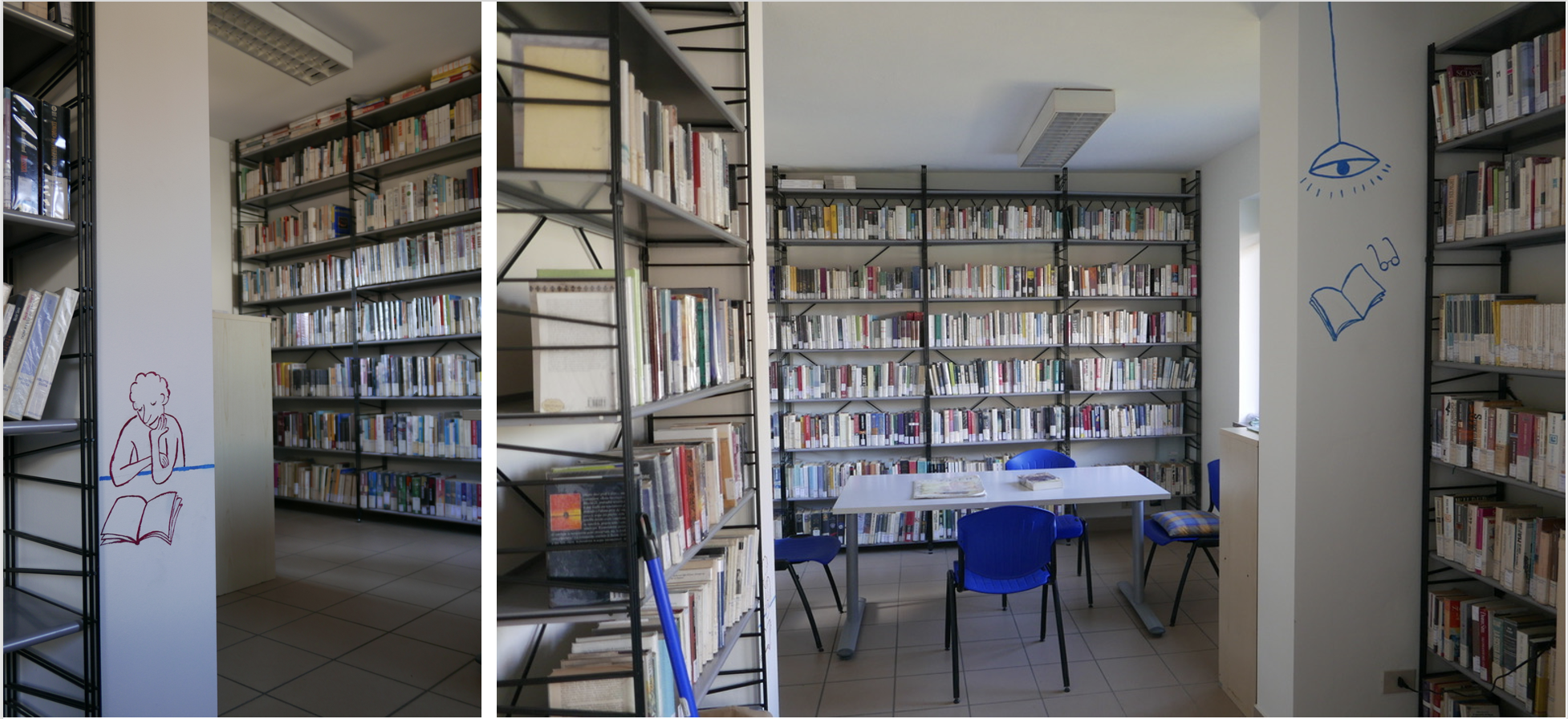Il De situ orbis di Pomponio Mela (I. sec. d.C.) è la più antica opera di geografia scritta in latino che sia giunta fino a noi, conosciuta anche con i titoli De chorographia oppure Cosmographia. L’opera, redatta intorno al 44 d.C., basata su fonti precedenti greche e romane (Cesare, Livio, Cornelio Nepote, Posidonio, Eratostene e Erodoto), si occupa dell’Ecumene (il mondo come conosciuto nell’antichità): dallo stretto di Gibilterra, ai limiti del Mediterraneo, fino all’Oriente. Mela descrive con particolare attenzione i luoghi abitati lungo le coste e più sommariamente i territori interni, e vuole definire quali possono essere i confini della Terra descrivendo i luoghi più remoti e poco conosciuti; infatti è uno degli scrittori più antichi a fare riferimento alla Cina definendo i suoi cittadini come seres genus plenum iustitiae (un popolo pieno di giustizia).
Gli antichi erano soliti dividere il mondo ad essi noto in varie parti. Per Mela la Terra è concepita come una sfera suddivisa in cinque regioni climatiche, due delle quali abitabili: quella a settentrione - che comprende il Mediterraneo e i territori circostanti, l’attuale Europa e parte dell’attuale Asia - e quella meridionale chiamata Antichthon o “antimondo”, di dubbia esistenza secondo l’autore.
Il mondo descritto ci appare piccolo rispetto alle conoscenze attuali, ma le esplorazioni si limitavano alle coste del Mediterraneo e del Mare Eritreo (oggi Mar Rosso), lungo il quale correva la via dell’Incenso (la strada carovaniera che collegava l'estremità della Penisola arabica), l’Africa del nord e parte dell’Asia. La presenza del deserto del Sahara non favoriva l’interesse dei Romani a una conquista dei territori subsahariani, e la tecnologia nautica non permetteva di attraversare gli oceani (anche per attraversare il Mediterraneo si preferiva navigare lungo la costa).
Il mondo descritto ci appare piccolo rispetto alle conoscenze attuali, ma le esplorazioni si limitavano alle coste del Mediterraneo e del Mare Eritreo (oggi Mar Rosso), lungo il quale correva la via dell’Incenso (la strada carovaniera che collegava l'estremità della Penisola arabica), l’Africa del nord e parte dell’Asia. La presenza del deserto del Sahara non favoriva l’interesse dei Romani a una conquista dei territori subsahariani, e la tecnologia nautica non permetteva di attraversare gli oceani (anche per attraversare il Mediterraneo si preferiva navigare lungo la costa).
Il libro conobbe molte edizioni, e nel XVIII secolo era utilizzato per lo studio del latino. Nella biblioteca di Biella si conservano oltre all’edizione del 1536 anche tre volumi stampati a Leida nel 1722, 1743 e 1748, una stampata a Glasgow nel 1752 e una stampata a Torino nel 1858. Gli esemplari del 1722, 1743, 1748 e 1752 fanno parte della donazione Cridis, tra queste le edizioni di Leida presentano un’antiporta allegorica con titolo Pomponius Mela A. Gronovii e presentano un frontespizio stampato in nero e rosso. Quelle del 1722 e del 1748 sono arricchite da diverse illustrazioni calcografiche prevalentemente numismatiche e da una carta di tavola ripiegata raffigurante l’ Orbis terrarum ex mente Pomponii Melae delineatus a P. Bertio.
Il volume del 1536 contiene anche l’unica opera che ci è pervenuta di Caius Iulius Solinus, scrittore romano del III. Sec., il Collectanea rerum memorabilium nota nel medioevo come Polyhistor. Elenca le meraviglie del mondo, le usanze e le informazioni più strane e curiose sui popoli, sulle piante e sugli animali, seguite dalla storia di Roma, dalle origini all’età augustea e da una disamina i Italia, Grecia, Germania, Gallia, Britannia, Spagna, Africa, Arabia, Asia minore, India e regioni del Mar Nero. Solinus si basa su fonti quali Plinio il Vecchio, Svetonio, Varrone e lo stesso Pomponio Mela.
L’esemplare è rilegato con una coperta in pergamena rigida, il dorso suddiviso in sei compartimenti da cinque nervature presenta un’etichetta in pelle con il nome dell’autore; è mutilo del frontespizio che è stato sostituito con una carta manoscritta che riporta titolo e dati dell’edizione. La lettera dedicatoria porta come indicazione di luogo di stampa Parigi e la data 1536.
Valeria Ceffa