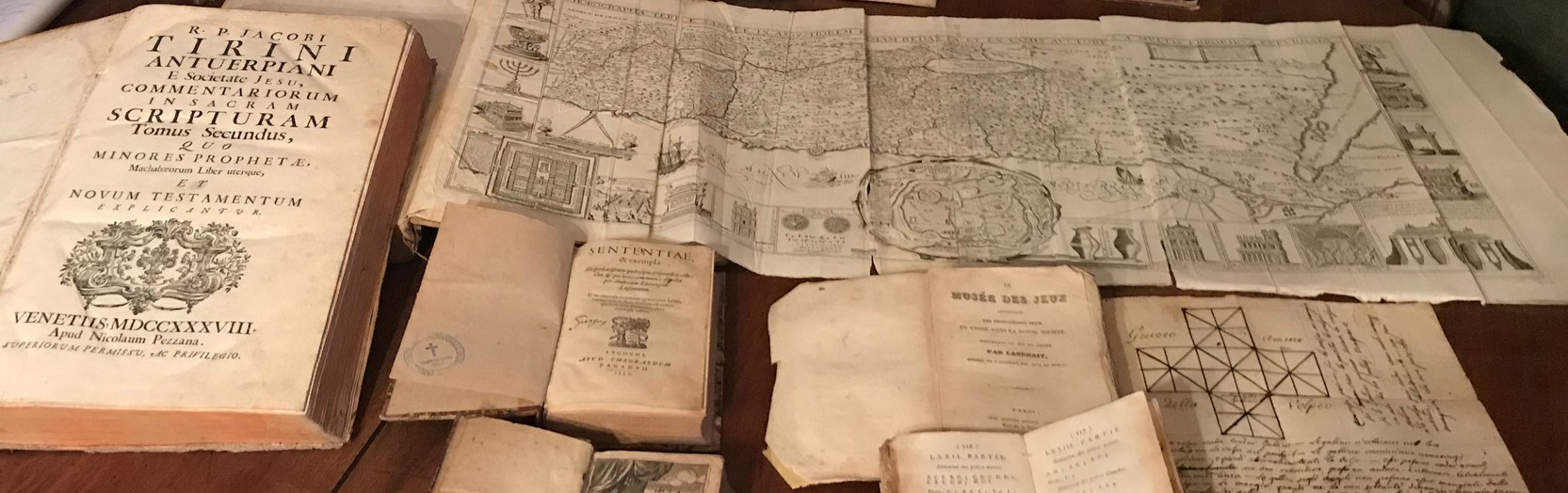Questo scritto, stampato a Parigi presumibilmente nel 1855, è un estratto della rivista francese Revue et magazin de zoologie (n. 10-1855) e descrive per la prima volta una nuova specie di Carabus, un piccolo coleottero scoperto nella nostra Valsessera in circostanze fortuite. L’opera, di 4 pagine, il cui autore è l’entomologo Eugenio Sella (1820-1882), è corredata da alcuni disegni che ne restituiscono la sua peculiare bellezza.
La pubblicazione fa parte di uno dei più importanti fondi della nostra Biblioteca Civica, denominato Miscellanea Sella (collocazione Zoologia 1/17), appartenuto a Quintino Sella, e donato nel 1909 dal figlio Corradino, allora Sindaco di Biella.
La pubblicazione fa parte di uno dei più importanti fondi della nostra Biblioteca Civica, denominato Miscellanea Sella (collocazione Zoologia 1/17), appartenuto a Quintino Sella, e donato nel 1909 dal figlio Corradino, allora Sindaco di Biella.
Tornando all’insetto oggetto della pubblicazione, si narra che una bambina di otto anni di nome Olimpia, mentre si trovava nei pressi del Bocchetto Sessera, avesse trovato un piccolo animale senza vita che destò la sua curiosità. Possiamo immaginare che la ragazzina, certamente curiosa e intenta a giocare scrutando fra le rocce e i sentieri di quelle erbose vallate, stesse inseguendo farfalle e libellule, rovesciando sassi per cercare piccoli e quanto mai misteriosi animaletti capaci di alimentare le fantasie innate dei bambini, magari sognando di essere una ricercatrice proprio come suo cugino Eugenio Sella. Ed ecco che, forse per gioco, oppure per sapere quale fosse il suo nome, Olimpia gli mostrerà il piccolo insetto da lei trovato e che si rivelerà ben presto una rarissima specie sconosciuta.
Eugenio quindi, nel descriverlo, lo chiamerà Carabus Olympiae, in onore e riconoscenza della cugina che lo trovò su quelle montagne nei primi giorni di settembre del 1854. L’entomologo, oltre a questa, nel 1873 scoprì altre due specie di coleotteri nella Valle Pesio.
Nella pubblicazione apparsa sul periodico transalpino, il Sella descrisse poi dettagliatamente il carabide, endemico della Valsessera, della lunghezza di circa 3 cm e dagli splendidi colori iridescenti verde smeraldo, dai contorni dorati. Egli, tuttavia, con l’intenzione di proteggere lo straordinario insetto e il suo fragile habitat, rimase piuttosto vago circa il luogo del ritrovamento, custodendo per anni questo segreto. Nel 1887 la località venne resa nota pubblicamente e, ben presto, divenne una meta ambita di studiosi e collezionisti che portarono l’animaletto sull’orlo dell’estinzione.
Eugenio quindi, nel descriverlo, lo chiamerà Carabus Olympiae, in onore e riconoscenza della cugina che lo trovò su quelle montagne nei primi giorni di settembre del 1854. L’entomologo, oltre a questa, nel 1873 scoprì altre due specie di coleotteri nella Valle Pesio.
Nella pubblicazione apparsa sul periodico transalpino, il Sella descrisse poi dettagliatamente il carabide, endemico della Valsessera, della lunghezza di circa 3 cm e dagli splendidi colori iridescenti verde smeraldo, dai contorni dorati. Egli, tuttavia, con l’intenzione di proteggere lo straordinario insetto e il suo fragile habitat, rimase piuttosto vago circa il luogo del ritrovamento, custodendo per anni questo segreto. Nel 1887 la località venne resa nota pubblicamente e, ben presto, divenne una meta ambita di studiosi e collezionisti che portarono l’animaletto sull’orlo dell’estinzione.
Nel 1864, in occasione di un incontro tenutosi a Biella della Società Italiana di Scienze Naturali, il Sella espose una relazione definita «interessantissima», come riportato nel libro Il Carabus Olympiae Sella dell’Alta Valle Sessera del 1983 (Pro Natura biellese), ricordando che le montagne biellesi, nonostante siano «un piccolo tratto delle Alpi pennine, pure [contengono] pressochè tutte le specie di Coleotteri […] oltre alcune sue speciali e rari». Nel corso della conferenza, presentò «per la prima volta in lingua italiana» il Carabus Olympiae, definendolo una «magnifica specie, che pei brillanti suoi colori non la cede che a poche sue congeneri dei Pirenei».
Maurizio Pavarin